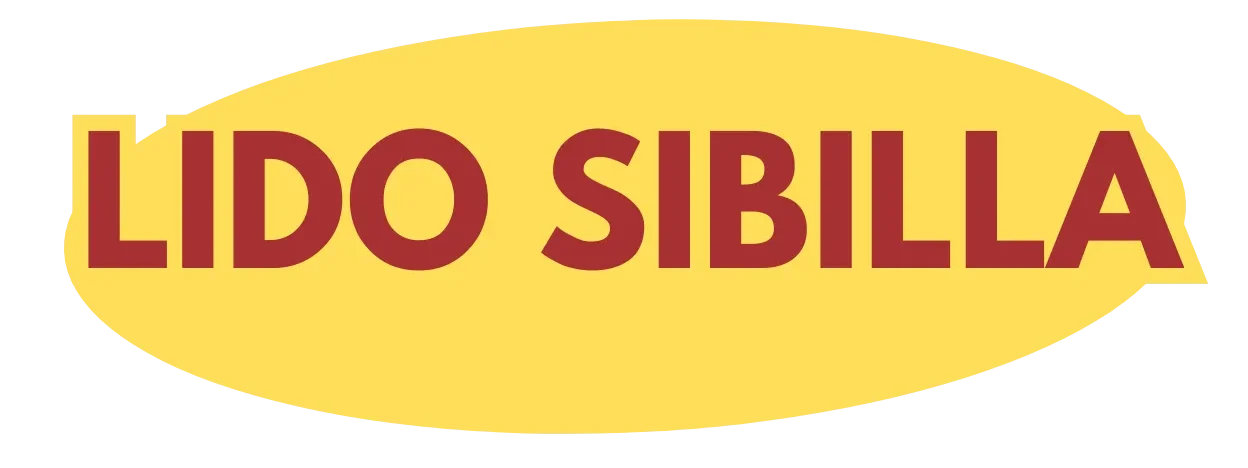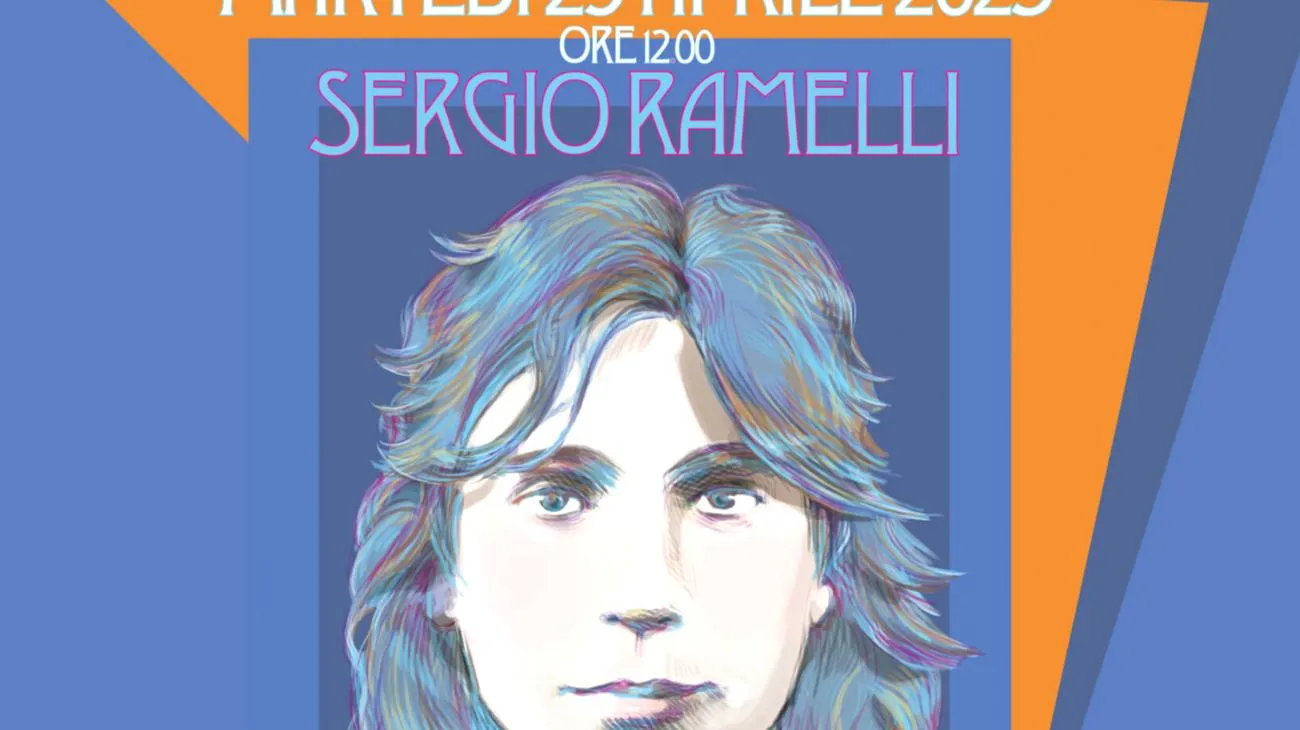Perché la nostra mente è così attratta dalle storie tragiche? Dall’11 settembre alla strage di Bologna, passando per drammi personali come quello di Sergio Ramelli, le narrazioni drammatiche si imprimono nella memoria collettiva con una forza sorprendente. Il motivo? Una combinazione di antichi meccanismi neurobiologici, dinamiche culturali e potere dei media, che insieme modellano ciò che scegliamo di ricordare come società.
Il cervello umano e il richiamo del negativo
Il nostro cervello è programmato per ricordare ciò che può rappresentare una minaccia. È una forma di difesa evolutiva: ricordare un’esperienza dolorosa poteva significare, per i nostri antenati, sopravvivere a una situazione simile in futuro. Questo meccanismo è noto come bias della negatività e si manifesta fin da piccoli, influenzando emozioni, decisioni e memoria.
Secondo il neuroscienziato Joseph LeDoux, emozioni forti – come paura, rabbia o dolore – attivano l’amigdala, la centralina emotiva del cervello che rafforza la formazione di ricordi duraturi. Ecco perché certi momenti traumatici restano impressi nella mente per anni o addirittura per tutta la vita.
Quando l’emozione diventa memoria collettiva
Eventi scioccanti, come attentati, disastri naturali o crimini politici, non si limitano a colpire il singolo individuo. Entrano nella memoria collettiva, diventano tappe condivise attorno a cui la società costruisce il proprio racconto. Il caso di Sergio Ramelli, assassinato nel 1975, ne è un esempio emblematico: la forza emotiva della sua storia continua a far discutere generazioni intere, simbolo di una cicatrice ancora aperta nella coscienza pubblica.
Questi ricordi non sono mai neutri, ma mediano valori e conflitti di chi li narra. Il sociologo Maurice Halbwachs ha spiegato come ogni comunità selezioni cosa commemorare e cosa, invece, cancellare. Il risultato? Una memoria filtrata che serve a rafforzare l’identità di un gruppo, anche a scapito della complessità storica.
Media tradizionali e social: amplificatori di tragedia
Dalla televisione ai social media, le notizie negative dominano la scena. Perché suscitano più condivisioni, attivano emozioni forti e fanno aumentare l’attenzione. Studi recenti confermano che le notizie con toni tragici o controversi vengono percepite come più importanti e hanno un impatto più duraturo nell’immaginario collettivo.
Lo stesso accade online: contenuti negativi, specie se moralmente carichi, hanno una probabilità molto più alta di diventare virali. Questo comporta una selezione dei ricordi pubblici in cui la tragedia ha spesso la meglio su storie positive o costruttive, contribuendo a un immaginario dominato dalla paura e dal conflitto.
Costruire un equilibrio: cosa possiamo fare
Riconoscere questa tendenza è il primo passo per costruire una memoria pubblica più equilibrata. Non significa ignorare gli eventi traumatici, ma ingrandire anche le narrazioni di resilienza, cooperazione e trasformazione.
- Includere nella narrazione storica prospettive diverse e meno rappresentate
- Valorizzare episodi positivi che mostrano il meglio della società umana
La consapevolezza del funzionamento della nostra memoria può renderci più critici e selettivi, aiutandoci a dare spazio anche a ciò che costruisce e unisce, non solo a ciò che sconvolge.
Ricordare il dolore, coltivare la speranza
Il nostro modo di ricordare definisce come comprendiamo il presente e immaginiamo il futuro. Le storie tragiche vanno conservate con rispetto e consapevolezza, come moniti e occasioni di riflessione. Ma è altrettanto importante non smettere di raccontare le storie di coraggio, umanità e rinascita.
Una memoria collettiva matura si costruisce con equilibrio: ricordando le ferite, ma anche celebrando le conquiste. Perché, alla fine, ciò che scegliamo di ricordare dice molto su chi siamo e su chi vogliamo diventare.
Indice dei contenuti